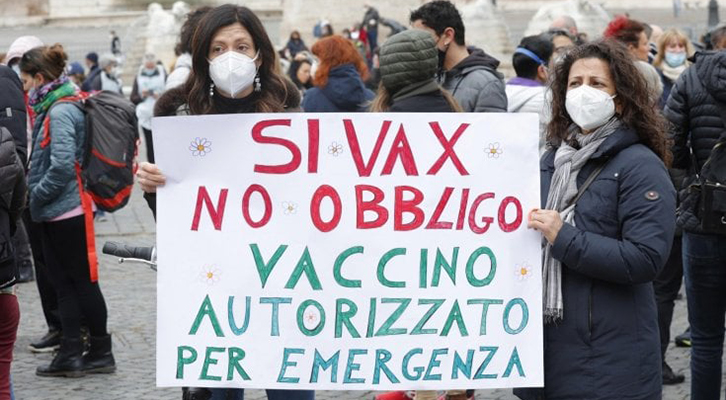Nel decreto Milleproroghe approvato martedì 10 dicembre dal Consiglio dei Ministri è stata inserita la cancellazione delle multe di 100 euro previste a suo tempo per i cosiddetti No Vax, ovvero coloro che si erano sottratti alla vaccinazione obbligatoria durante l’epidemia di Covid-19.
 Già l’annuncio della misura aveva suscitato un prevedibile vespaio, segno della mancata assimilazione dei valori in gioco, nonché della confusione dei riferimenti cui ancorare i giudizi, e della trascuratezza delle prospettive coinvolte.
Già l’annuncio della misura aveva suscitato un prevedibile vespaio, segno della mancata assimilazione dei valori in gioco, nonché della confusione dei riferimenti cui ancorare i giudizi, e della trascuratezza delle prospettive coinvolte.
Sarebbe quindi utile ripassare l’evoluzione giurisprudenziale riguardo l’obbligo vaccinale.
I valori contemperati nelle pronunce e la loro analisi sono già stati oggetto di un approfondimento riguardo le sentenze più risalenti, lasciando al presente contributo le questioni sulle pronunce della Consulta del febbraio 2023 e il Dl 44/2021.
Il ruolo della Corte Costituzionale
Nella relazione annuale 2024, datata 18 marzo 2024, giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19, si è richiamato il bilanciamento operato dalle sentenze n.14-16/2023, relative al personale sanitario, e la 15/2023 relativa agli impiegati in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali.
In queste pronunce è stata esclusa l’illegittimità dell’obbligo vaccinale ritenendo razionale (meglio, non irragionevole) il bilanciamento operato dal legislatore fra le libertà individuali e il diritto fondamentale alla salute, definito dall’art. 32 della Costituzione anche come «interesse della collettività», sulla base di dati scientifici disponibili, tenendo conto di quanto realizzato in altri ordinamenti omogenei a quello italiano.
I riferimenti, già richiamati nel precedente approfondimento, da tenere a mente, sono non solo il miglioramento della salute del singolo, ma la preservazione della salute altrui, con un margine di discrezionalità delle misure a seconda dell’andamento epidemiologico.
Ebbene, posto che la preservazione della salute del singolo comprende anche la non nocività delle sostanze, tranne per le conseguenze normali e tollerabili — questione importante, ma che risente di margini di interpretazione e di fiducia sui dati variabile, incidendo tale percezione sulla volontà individuale —, il focus sembrerebbe essere quindi sull’interesse collettivo alla salute.
Questo si declina in due modi, sia nel preservare la salute altrui, non mettendo in sofferenza il sistema sanitario con cure più difficili e quindi adeguandosi alla prevenzione delle conseguenze gravi della malattia, sia nel fare argine all’epidemia rendendone il decorso sempre più blando.
Ovviamente, il ruolo delle conoscenze scientifiche gioca qui un ruolo determinante.
L’effetto non immunizzante del vaccino
Se la comunicazione ufficiale, portava a credere che la necessità della vaccinazione fosse correlata ad interrompere la trasmissibilità del virus, con ciò conducendo ad una fallacia del discorso in argomento, la stessa mutazione del virus non può certamente giocare un ruolo secondario nella predisposizione delle misure coercitive ad hoc.
I vaccini contro il Covid-19 non sono infatti stati specificamente autorizzati per prevenire la trasmissione del virus Sars-CoV-2 da una persona all’altra. Ciò non esclude un loro utilizzo anche per ridurre la trasmissione del virus, ma le finalità vaccinali prioritarie sono state altre.
Si deve dire, a tale riguardo, che studi successivi hanno dimostrato una maggiore persistenza del livello di anticorpi, soprattutto con la terza dose o con un’immunizzazione precedente per aver contratto il virus, rispetto al deterioramento di tre mesi che si era ipotizzato all’inizio.
Tuttavia, la proliferazione di varianti, e l’aumento del coefficiente di trasmissibilità, ha portato a considerare secondario l’obiettivo di ridurre la trasmissibilità.
La posizione dell’Istituto Superiore di Sanità
La pronuncia 14/2023 affronta anche questo argomento in quanto sollecitata correttamente dal Giudice remittente: «La vaccinazione anti Covid-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2.
Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l’elevata efficacia dei vaccini anti Covld-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).
Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l’immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell’Iss).
L’Istituto chiarisce, inoltre, che «anche se l’efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l’elevata circolazione del virus Sars-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell’Iss)»
Come si vede le varianti pongono in rilievo l’obiettivo di ridurre le forme gravi della malattia.
L’effetto preventivo del tampone
Questo, se comparato all’altro strumento utilizzabile per la prevenzione dei casi, ossia il tampone, comporta un differente bilanciamento che viene avvertito anche nella pronuncia n.15/2023: «Non può certamente ritenersi che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell’infezione da Sars-CoV-2 con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un’alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore.
Invero, la soluzione alternativa proposta dal rimettente è stata utilizzata in ambiti più generali, per l’accesso ai luoghi pubblici da parte di persone non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria.
Tuttavia, non può non considerarsi, innanzitutto, che, nel caso degli operatori sanitari, tale soluzione sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale.
Inoltre, l’effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata (e cioè ogni due o tre giorni) avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia» (in tal senso vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza n.14 del 2023).
Ebbene, questa sentenza nel difendere la scelta impositiva del vaccino per alcune categorie enuncia un principio giusto, quello di garanzia della prestazione sanitaria, garanzia tuttavia posta in discussione proprio dall’obbligo vaccinale, in quanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative degli operatori sanitari.
Per quanto riguarda i costi economici e organizzativi del Sistema Sanitario Nazionale, questi sarebbero stati compensati dal minore impatto del virus in dette strutture, ossia inibendo proprio il decorso grave e fatale per le persone più deboli, anche quelle impossibilitate a vaccinarsi.
I numerosi focolai negli ospedali stanno a testimoniare l’incidenza di questi eventi sull’impennamento dei numeri.
L’effetto cintura di sicurezza, ossia quella falsa sensazione di argine dato dal vaccino, percezione confermata anche ai vertici dello Stato, vedasi le affermazioni del Presidente Draghi, non ha giocato un ruolo secondario in questo bilanciamento.
Con un successivo contributo si porterà l’attenzione sulle multe agli ultracinquantenni.
Armando Mantuano *avvocato